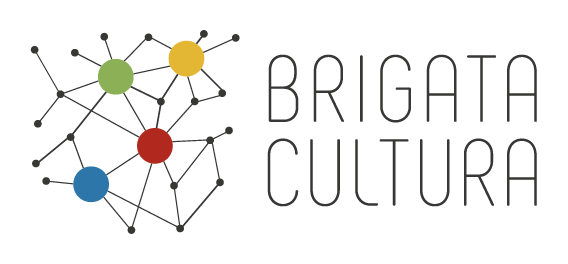Nel 1915, sulla scia dell’entusiasmo siderurgico dettato dalla Prima Guerra Mondiale viene intrapresa la costruzione del Lingotto che da lì a poco sarebbe stato teatro del febbrile successo della Fiat: inizialmente divisa tra via Madama Cristina e Corso Dante, la Fabbrica Italiana Automobili Torino nata nel 1899, condensa finalmente la produzione in un unico grande stabilimento che riprende quello della Ford ad Highland Park (USA) visitato da Giovanni Agnelli nel 1912.
L’Ingegnere Mattè Trucco e, per quanto riguarda l’architettura strutturale, l’ingegner Porcheddu sono i progettisti di ciò che pare un grattacielo sdraiato, o per utilizzare una definizione di Le Corbusier che parla del Lingotto nel 1923 nel suo libro Vers une Architecture, «una nave da guerra». Appoggiata sul tetto, come una corona, la pista di collaudo si snoda per un chilometro (500m per lato) piegandosi in due curve agli estremi nord e sud per unire i due bracci.
 Sopra la pista, un altro grande progettista, l’architetto Renzo Piano, fa apparire in tempi più recenti una sfera di vetro e uno scrigno; la prima come sala riunioni servita da un eliporto, il secondo pensato per custodire alcune delle opere d’arte dell’immensa collezione di Gianni e Marella Agnelli: una selezione di 25 capolavori che vanno da Canaletto a Picasso passando per Canova e Matisse.
Sopra la pista, un altro grande progettista, l’architetto Renzo Piano, fa apparire in tempi più recenti una sfera di vetro e uno scrigno; la prima come sala riunioni servita da un eliporto, il secondo pensato per custodire alcune delle opere d’arte dell’immensa collezione di Gianni e Marella Agnelli: una selezione di 25 capolavori che vanno da Canaletto a Picasso passando per Canova e Matisse.
L’idea di un museo per la propria collezione nasce nella mente dell’avvocato già negli anni ’60 quando pensa di affidarne la realizzazione a Carlo Scarpa che ha appena completato l’allestimento degli Uffizi, quello di Palazzo Abatellis a Palermo ed è il firmatario del padiglione Italia alla Biennale Veneziana del 1952.
L’idea iniziale di costruire il museo a Villar Perosa, paese d’origine della famiglia Agnelli, viene abbandonata: un intervento di questo genere rischierebbe di turbare la pace della Val Chisone rompendone il silenzioso equilibrio. Così il progetto del museo subisce una battuta d’arresto, ma negli anni ’90 la fase di rifunzionalizzazione del Lingotto in seguito allo spostamento di tutta la produzione a Mirafiori fornisce lo spunto per una location alternativa: Agnelli costruisce il museo sopra quella che era stata la fabbrica di suo nonno, rinsaldando il legame tra la su famiglia, la FIAT e Torino.
Salendo le scale dal livello della pista, la Pinacoteca si apre con un enorme quadro futurista di Giacomo Balla che racconta La velocità astratta di un’automobile in corsa, come se tra l’asfalto del circuito sottostante e il museo non ci fosse interruzione.
Sulla parete opposta è appeso un piccolo Severini del 1915, con Lanceri al galoppo, acquistato da Agnelli perché gli ricorda di quando, ufficiale di cavalleria, aveva combattuto in Russia ed in Africa e poi in Italia con gli Alleati.
 Ci sono ben sei tele veneziane di Canaletto (due arrivano dall’abitazione torinese degli Agnelli, le altre quattro sono state acquistate nel 2000 appositamente per essere esposte nella Pinacoteca) e due del nipote Bernardo Bellotto dipinte a Dresda per l’elettore di Sassonia e utilizzate dopo la Seconda Guerra Mondiale come documento visivo per ricostruire la città rasa al suolo dai bombardamenti.
Ci sono ben sei tele veneziane di Canaletto (due arrivano dall’abitazione torinese degli Agnelli, le altre quattro sono state acquistate nel 2000 appositamente per essere esposte nella Pinacoteca) e due del nipote Bernardo Bellotto dipinte a Dresda per l’elettore di Sassonia e utilizzate dopo la Seconda Guerra Mondiale come documento visivo per ricostruire la città rasa al suolo dai bombardamenti.
C’è poi la sala che ospita la collezione italiana più ricca di Matisse: ben sette quadri che vanno dal 1920 al 1948, tutti interni coloratissimi dove il pittore francese racconta nature morte, tessuti, fiori, frutta, finestre spalancate sul mare.
In questo viaggio senza ordine, né criterio, se non quello del piacere della bellezza, si approda a Picasso presente con due tele, una del periodo blu, dove una prostituta ingioiellata galleggia su uno sfondo vuoto fissando lontano con gli occhi arrossati, l’altra, cubista, dove la figura di un uomo è resa architettonicamente dal giustapporsi di rettangoli e quadrati che ne raccontano la staticità e la posizione eretta.

Se ci si volta ecco poi due nudi: uno candido, morbido, memore delle carni di Michelangelo (è Aline, la modella e amante di Renoir dipinta a Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo) l’altro è sanguigno, rosso come il divano sul quale è sdraiato; Modigliani lo dipinse a Parigi nel 1917, quando fece la sua prima mostra che venne chiusa per oltraggio al pubblico pudore.
Di fianco ai nudi, un poco vergognosa, La negresse di Manet osserva il visitatore: è la stessa donna che nell’Olympia porge il mazzo di fiori alla prostituta languidamente sdraiata. Zola si complimenta con l’amico Manet in una lettera: questo, lungi da essere uno studio, è il primo ritratto di una donna nera ad essere dipinto come tale e non con intento antropologico o colonialista. Non è una selvaggia, non è una odalisca, non è una serva, è semplicemente una donna.
All’elenco mancano ancora due gessi di Canova e un frammento di Tiepolo con un alabardiere; il quadro venne tagliato nell’Ottocento e per vedere il pezzo mancante bisogna volare fino alla National Gallery of Scotland a Edimburgo dove è conservata la scena principale: il ritrovamento di Mosè da parte della figlia del Faraone.
Forse più nota all’estero che a Torino la Pinacoteca Agnelli contiene preziosissimi capolavori scelti per la loro bellezza e il piacere che procurano più che per un progetto storico-artitico precostituito; come ha detto l’Avvocato «una collezione è una confessione»: in queste opere possiamo leggere la storia del loro autore, quella dei collezionisti che le hanno possedute, ma anche quelle dei due coniugi Agnelli che le hanno acquistate e quella dell’edificio che ora, orgogliosamente sul capo, le porta.
Elena Patrignani