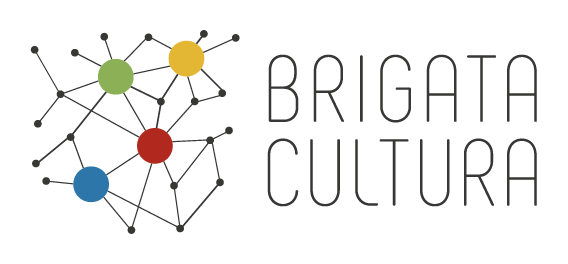“Quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuoi occhi…”.

Ecco le parole usate dall’artista ebreo di origine livornese, che svolse la sua breve carriera artistica nella rumorosa e viziosa Parigi del primo ventennio del Novecento, per rivolgersi alla sua giovane amata, Jeanne Hébuterne, compagna, pittrice, modella e madre sventurata dei suoi figli. A lui è dedicata l’interessante mostra “Modigliani e la Bohème di Parigi” allestita alla GAM di Torino da Mondo Mostre Skira in collaborazione con il Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou di Parigi.
Se volessimo condensare il concetto artistico di Modigliani usando poche semplici espressioni potremmo sfruttare quelle medesime parole, poiché tutta la sua arte è una negazione della ricerca della verisimiglianza, ma una sempre maggiore spersonalizzazione della figura, una progressiva semplificazione e schematizzazione dei profili, per giungere alla forma epurata, essenziale, astratta. Gli occhi, quelle mandorle nere incastonate senza pupille, non erano importanti quanto l’anima dell’effigiato. Ecco il ribaltamento di un principio fondante tutta l’arte classica: la rappresentazione della realtà come si presenta ai nostri occhi, la sua instabile apparenza, è subordinata alla rappresentazione dell’essenza dei soggetti. Tutta la vicenda di Modigliani, personale e artistica, si potrebbe riassumere nel tragico tormento di un uomo segnato dalla tubercolosi e dalla conseguente e assoluta necessità di godere con cattiveria di ogni momento, finché possibile. Egli morì poco più che trentaseienne a Parigi, ormai consumato dagli spasmi della malattia e dalle ricorrenti dissolutezze di un’esistenza votata all’alcol e alle droghe. La sua vita fu una sorta di percorso involutivo dai primi moderati anni nella Toscana di fine Ottocento alla progressiva autodistruzione cominciata dal suo determinante trasferimento nel 1906 nella Parigi della Bohéme, tra Montmartre e Montparnasse. In un solo anno, il Modigliani che, nonostante la miseria in cui versasse, teneva a mantenere un aspetto distinto e per nulla decadente, deprecando, al contrario, la trasandatezza del geniale Pablo Picasso, divenne una sorta di paradigma dell’artista maledetto, sregolato, dissoluto, trasandato, sempre ubriaco al limite del tracollo etilico e per questo creatore di un’aura mitica non meno affascinante di quella che si era aggiudicata in anni recenti Vincent Van Gogh.
In breve tempo stravolse la sua arte, nata in Italia sulla scorta delle armoniche regolarità del Rinascimento e sulle piane vibrazioni luministiche della pittura macchiaiola, e rinnegò tutto il suo passato, che etichettava come “borghese”, distruggendone anche le prime sperimentazioni grafiche e pittoriche. Nonostante i primi inevitabili influssi delle Avanguardie storiche francesi (il post-impressionismo di Cezanne, il Cubismo di Picasso e Braque e gli arcaismi dei Fauves), in poco tempo Modigliani si creò uno spazio operativo assolutamente autonomo, rimanendo sempre ai limiti dell’appartenenza a un movimento o una corrente, e si interessò di scultura attraverso l’opera dello scultore rumeno Brancusi. Nel 1914 cominciò a dedicarsi in maniera esclusiva alla pittura componendo quei ritratti e nudi che lo avrebbero reso celebre da subito dopo la morte, nel 1920, sino ai giorni nostri.
L’esperienza di Modigliani è quella dell’artista eccentrico, che intese l’arte come il campo attraverso cui dar voce ai propri travagli uterini. L’arte più autentica e anticonformista, che non si prestò alle rassicuranti leggi del mercato, come tanti artisti a lui coevi intesero, affidando i propri affari e la propria creatività al fiuto di abili impresari. Un’arte sincera, personalissima, che diventò il luogo in cui trascurare le leggi della tecnica imposte dalle accademie per imporre unicamente la propria anima, il proprio Io come vero sovrano della composizione. Non esiste necessario naturalismo nei ritratti, se non la sola impellenza di far passare un ricordo, un’emozione o un senso puntuale legato al personaggio. Ecco perché trasfigurarli e renderli quanto meno umani, ma quasi più simili, nelle loro linee elementari, ai mascheroni primitivi della tradizione africana o khmer. L’importante era che l’essenza si imponesse alla verisimiglianza; l’incorruttibilità di quell’anima, che, lui lo sapeva, in un corpo ormai consunto dalla malattia e dai vizi, era l’unica in grado di eternare la persona.
Giusi Giamportone